
L’introduzione del concetto di “competenza” nella pedagogia scolastica è piuttosto recente, e non esiste una sua definizione precisa da tutti condivisa.Il motivo per cui si è cominciato ad affermare che le conoscenze acquisite a scuola devono diventare “competenze” è collegato alla critica di modi di apprendere privi di una vera comprensione delle conoscenze e tendenti al verbalismo, alla mera capacità di “parlare” di certi argomenti, senza averne vera consapevolezza e senza sapersene servire al di fuori del contesto scolastico.Il concetto di competenza è stato perciò legato alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, che non riguardano solo prestazioni riproduttive, ma anche la soluzione di problemi.
In genere, si ritiene che
alla competenza, così sommariamente concepita, si debba riconoscere una
struttura complessa, che tiene insieme vari aspetti che spesso tendiamo a
distinguere e a contrapporre.
 In primo luogo, nella
competenza è presente sia un aspetto “esterno”, la prestazione adeguata, sia
uno “interno”, la padronanza mentale dei processi esecutivi; perciò, una
competenza si definisce sia sul piano della performance osservabile
(come volevano i comportamentisti), sia su quello del flusso delle operazioni
cognitive che si compiono “nella testa” dell’alunno (come indicano i
cognitivisti). In secondo luogo, una competenza implica contemporaneamente un
“sapere” e un “saper fare” (o, come si dice nel gergo psicopedagogico, unisce
la conoscenza dichiarativa e quella procedurale), perché le conoscenze non
devono soltanto essere ripetute verbalmente, ma devono essere usate come
strumenti d’azione (nella soluzione di problemi, per esempio).In terzo luogo,
la competenza richiede sia la “cognizione” che la “metacognizione”; infatti,
una vera competenza non si limita alla padronanza dell’esecuzione, ma comprende
una certa rappresentazione della sua struttura e dei suoi criteri, anche se
questa non giunge necessariamente alla capacità di descrizione verbale;
quest’ultima, la capacità non solo di fare, ma di spiegare come si fa e perché,
distingue propriamente l’esperto (colui che ha familiarità con un compito) dal
principiante.Infine, nella competenza sono connessi tanto aspetti “cognitivi”
quanto “affettivi”, poiché essa coinvolge anche atteggiamenti (la disponibilità
ad impegnarsi nel campo in cui ci si sente competenti, per esempio) e
motivazioni (per esempio, la “motivazione alla competenza”: la spinta ad agire
con successo ed efficacia).
In primo luogo, nella
competenza è presente sia un aspetto “esterno”, la prestazione adeguata, sia
uno “interno”, la padronanza mentale dei processi esecutivi; perciò, una
competenza si definisce sia sul piano della performance osservabile
(come volevano i comportamentisti), sia su quello del flusso delle operazioni
cognitive che si compiono “nella testa” dell’alunno (come indicano i
cognitivisti). In secondo luogo, una competenza implica contemporaneamente un
“sapere” e un “saper fare” (o, come si dice nel gergo psicopedagogico, unisce
la conoscenza dichiarativa e quella procedurale), perché le conoscenze non
devono soltanto essere ripetute verbalmente, ma devono essere usate come
strumenti d’azione (nella soluzione di problemi, per esempio).In terzo luogo,
la competenza richiede sia la “cognizione” che la “metacognizione”; infatti,
una vera competenza non si limita alla padronanza dell’esecuzione, ma comprende
una certa rappresentazione della sua struttura e dei suoi criteri, anche se
questa non giunge necessariamente alla capacità di descrizione verbale;
quest’ultima, la capacità non solo di fare, ma di spiegare come si fa e perché,
distingue propriamente l’esperto (colui che ha familiarità con un compito) dal
principiante.Infine, nella competenza sono connessi tanto aspetti “cognitivi”
quanto “affettivi”, poiché essa coinvolge anche atteggiamenti (la disponibilità
ad impegnarsi nel campo in cui ci si sente competenti, per esempio) e
motivazioni (per esempio, la “motivazione alla competenza”: la spinta ad agire
con successo ed efficacia).
Se l’analisi del concetto di
competenza suggerisce che siano implicati questi diversi aspetti, questo non
significa però che essi siano sempre chiaramente distinguibili o separabili, e
ancora meno che si possano acquisire isolatamente gli uni dagli altri, come
avviene per ciò che definiamo una “abilità” (che in una certa misura può essere
analizzata in sotto-abilità, almeno in parte assimilabili separatamente o in
sequenza). Probabilmente, si è più vicini al vero se si considerano gli aspetti
della competenza come “ingredienti” che l’alunno aggiunge progressivamente e
che si “amalgamano” nel corso dell’esperienza. In ogni caso, della competenza
non si dà un “algoritmo”, ossia una serie di regole che basta applicare per
agire con efficacia; anche se la pratica esperta segue dei principi, si
capiscono veramente e s’impara ad adoperarli soltanto nel corso della pratica
stessa. Per acquisire competenza, è perciò necessario impegnarsi in certe
attività, con l’aiuto di una guida adeguata. La competenza nella ricerca
storica, per esempio, richiede cognizioni storiche e conoscenza dei principi
dell’indagine, ma la si acquisisce veramente soltanto facendo ricerca con la
guida di un soggetto esperto.
A questi elementi di carattere
generale sulla nozione di competenza, occorre unire l’uso che ne fanno le nuove
Indicazioni per il curricolo.
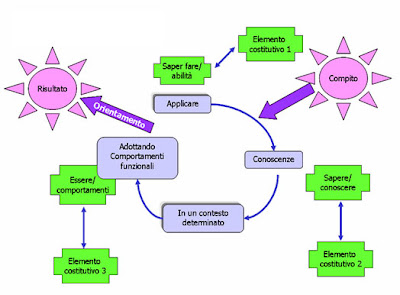 Le Indicazioni
parlano di “traguardi di sviluppo della competenza”. La competenza, perciò, è
considerata come qualcosa che si “sviluppa”, che ha un processo di incremento
che richiede un certo periodo di tempo. Infatti, tali “traguardi” sono proposti
come terminali, si riferiscono cioè alla fine della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; come dire: il
raggiungimento di un dato livello di competenza richiede un intero grado
scolastico.Per questo raggiungimento, inoltre, vengono indicati come
“strategici” gli “obiettivi di apprendimento”, suggerendo così che lo sviluppo
delle competenze è un processo indiretto, e rappresenta un effetto collaterale
e di lungo termine del conseguimento di tali obiettivi.
Le Indicazioni
parlano di “traguardi di sviluppo della competenza”. La competenza, perciò, è
considerata come qualcosa che si “sviluppa”, che ha un processo di incremento
che richiede un certo periodo di tempo. Infatti, tali “traguardi” sono proposti
come terminali, si riferiscono cioè alla fine della scuola dell’infanzia, della
scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado; come dire: il
raggiungimento di un dato livello di competenza richiede un intero grado
scolastico.Per questo raggiungimento, inoltre, vengono indicati come
“strategici” gli “obiettivi di apprendimento”, suggerendo così che lo sviluppo
delle competenze è un processo indiretto, e rappresenta un effetto collaterale
e di lungo termine del conseguimento di tali obiettivi.
Gli obiettivi sarebbero cioè
gli intermediari per assicurare lo sviluppo delle competenze. Non si deve
perciò pensare che la progettazione per obiettivi vada sostituita con una
progettazione per competenze; si sarebbe decisamente fuori strada; anzi,
rispetto al quadro che emerge dalle Indicazioni, un’espressione come
“progettare per competenze”, che può avere un suo senso come livello ulteriore
della progettazione, deve essere usata con molta cautela, perché la sua logica
risulta inevitabilmente diversa da quella pertinente per gli obiettivi. A
questo proposito, un’ipotesi che mi pare coerente (o per lo meno non
contraddittoria) rispetto al testo delle Indicazioni è che il senso
progettuale del concetto di competenza sia quello di suggerire criteri che
vincolano le modalità di raggiungimento degli obiettivi, se si vuole che questi
conducano a sviluppare competenze. In altre
parole, se è vero che vi sono molti modi di procedere per conseguire gli
obiettivi, nondimeno solo una parte di essi porta far crescere “competenze” nel
significato che abbiamo sommariamente indicato più su. In merito a ciò, nelle Indicazioni
sono suggerite metodologie didattiche che possono essere interpretate come
misure per garantire il passaggio dagli obiettivi alle competenze.






